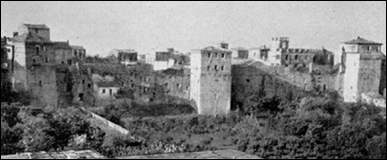
TERRACINA - Mura e Torri Urbane |
Secondo la tradizione, la chiesa di Terracina sarebbe stata fondata dallo
stesso Principe degli Apostoli che vi avrebbe nominato vescovo S. Epafrodito,
tuttavia bisogna scendere all'inizio del IV secolo per trovare un vescovo
Sabinus e Terracina storicamente sicuro, il quale partecipò al concilio
Romano in cui furono condannati i donatisti.
Ed anche i Cristiani di
Terracina, nel periodo delle persecuzioni, ebbero i loro martiri ed i loro
confessori dei quali il più famoso è S. Cesario, il patrono della
città, martirizzato probabilmente all'epoca di Decio Traiano (249-251).
Duramente devastata nel periodo delle invasioni barbariche, la vita non si
spegne nella nostra città, la quale ebbe una notevole ripresa proprio
sotto un re barbaro, Teodorico (457-526). Sotto questo sovrano, secondo ci
attesta un'antica iscrizione esistente a Mesa, furono fatti importantissimi
lavori di bonifica nella Palude Pontina intesi soprattutto alla riattivazione
dell'Appia andata sommersa.
Durante le campagne tra Ostrogoti e Bizantini,
Terracina, in conslderazione dell'importanza strategica della città,
venne cinta di nuove, poderosissime mura, delle quali restano tuttora tratti
imponenti.
I Longobardi, succeduti ai Bizantini in Italia, cominciano a
molestare dalla parte di mezzogiorno Terracina, ed il papa S. Gregorio Magno
(590-603), nella carenza delle autorità imperiali, dovette interessarsi
delle sorti della città, porta del Lazio, corrispondendo stipendi ai
soldati ed incitando i cittadini alla difesa delle mura: ed è guesta una
fra le prime manifestazioni politiche del papato che prelude alla formazione del
dominio temporale ecclesiastico. Costituito questo giuridicamente con la
donazione di Pipino (755), il nuovo stato doveva avere per limite meridionale
appunto la città di Terracina. I Greci di Gaeta, alleati con i Longobardi
di Benevento, nel 778 occuparono la città, ma ne furono scacciati dalle
milizie spedite da Adriano I, è la prima volta che il pontefice fa guerra
come principe temporale e conquista una città con le armi.
Succede
un lungo periodo di decadenza e di oscurità fino all'anno 1000, quando
Terracina fu concessa da Silvestro II in feudo a Dauferio II conte di Traietto.
Intanto si andava formando anche nella regione di Marittima e Campagna, un
nuovo organismo politico, il Comune, che viene riconosciuto di diritto in
Terracina dal privilegio di un papa, Gregorio VI o VII, che concede a tutti i
terracinesi la città ed il suo territorio con l'esercizio di pubblici
poteri.
Nel 1074, Ambrosio, eletto vescovo di Terracina, fece la
consacrazione della cattedrale; e nella cattedrale appena rinnovata il 12 marzo
nell' 1088 fu eletto ed incoronato il papa Urbano II, il banditore della I
Crociata ed il primo pontefice creato fuori di Roma.
Celestino II
(1143-1144) concesse in feudo Terracina alla famiglia dei Frangipane penetrati
per tradimento entro le mura cittadine ed impadronitisi del Castello, la Rocca
Traversa. Contro le angherie dei Frangipane si svolge la resistenza e la lotta
incessante da parte del Comune e nel 1202 i cittadini, insorti con estrema
violenza, assaltano, espugnano e diroccano il castello: non contenti, l'anno
successivo s'impadroniscono della rocca del Circeo, e nonostante gli ordini
papali, rifiutano di riconsegnarla ai Frangipane.
Coinvolto in una lunga
serie di contrasti intestini e di lotte con potenti signori limitrofi, nel 1295
il Comune elesse podestà Bonifacio Vlll (1294-1303) il quale, con estrema
energia, pacificò la città, sopì le fazioni, riordinò
le finanze comunali, accrescendone i proventi.
Durante il soggiorno dei
papi in Avignone, Terracina dovette tollerare l'egemonia di Roberto d'Angiò,
re di Napoli, egemonia sopportata soprattutto per averne tutela contro le
insidie dei Caetani di Fondi, i quali, non contenti di aver occupato il Salto,
miravano ad insignorirsi anche della città. Contro la minaccia incombente
di Niccolò Caetani, che aveva occupato i fortilizi di Monte S. Angelo nel
1346, i Terracinesi si rivolsero per aiuto a Domenico Garibaldo, comandante di
una flotta di 36 galee genovesi, riuscendo a sventare il pericolo ed a
riprendere tutto il territorio conquistato dal Conte.
Durante il secolo XV
Terracina ebbe la breve signoria di Ladislao, re di Napoli e successivamente
della sorella Giovanna II (1414-1435): ma i Terracinesi, non appena giunse la
notizia che nel Concilio di Costanza era stato eletto a pontefice Martino V,
insofferenti della dominazione napoletana, insorsero violentemente e scacciarono
gli occupatori della città ed alla regina Giovanna non rimase che
restituire Terracina al Papa (1420).
Alfonso d'Aragona la rioccupa nel 1435
e nel trattato del 1443, stipulato proprio in Terracina dal cardinale Scarampo,
legato di Eugenio IV, e dal re Alfonso, il papa infeudava Alfonso del Regno di
Napoli e gli lasciava anche Terracina, per quanto parte del territorio
pontificio, finchè vivesse.
Dissidi inesauribili e lotte intestine
travagliarono a lungo i cittadini divisi in opposte fazioni aragonese,
pontificia, francese, fino a quando, per l'intervento del papa Alessandro VI il
18 agosto 1499 si giunse alla pacificazione generale: ma con questo atto la vita
del Comune autonomo può considerasi finita.
Dal principio del '500,
in seguito ad una recrudescenza dell'infezione malarica, si manifesta quel
processo di scadimento demografico ed economico che si concluderà nel
1572 in seguito all'epidemia del "castrone" colla rovina quasi
completa della popolazione, ridotta a 40 fuochi (150 ab. circa). L'abbandono
della città, durato circa un secolo e mezzo, fu quasi completo, e questa è
la ragione per la quale molti edifici pubblici e privati e tutte le chiese
andarono completamente in rovina e cosi perirono quasi tutte le opere artistiche
che decoravano le ultime.
Il problema della bonifica pontina, di cui già
si erano occupati Leone X e Sisto V, venne affrontato ed in gran parte risolto
dal pontefice Pio VI (1775-99) ed è a questo papa, che venne a Terracina
per ben 16 volte, che va attribuito il merito della profonda trasformazione
urbanistica della città, con la creazione del nuovo borgo la Marina, tra
i piedi della città alta e la spiaggia di Levante ed i moli dell'antico
porto romano.
L'occupazione francese dello Stato ecclesiastico e la
proclamazione della Repubblica romana erano mal tollerate anche dalla nostra
popolazione. Memorabile è la sommossa popolare del 1798 repressa
sanguinosamente e dopo accanita resistenza dalle truppe franco-polacche,
presente lo stesso comandante supremo Mac Donald .
Ricomposto l'antico
ordine di cose dopo la caduta di Napoleone, a Terracina, nel 1818, si concluse
fra Pio VII e Ferdinando I il celebre Concordato che regolò e defini la
secolare controversia dei rapporti giurisdizionali del Papa sul Regno di Napoli.
Nel 1839 e nel 1843 Gregorio XVI si portò a Terracina dove visitò
anche i lavori del nuovo porto-canale intrapresi per sua volontà nel
1840. Pio IX, che nella sua fuga da Roma a Gaeta (24 novem. 1848) passò
in incognito per Terracina, vi ritornò nel 1850 accolto dalla popolazione
esultante. Ma gli eventi precipitano ed il 14 settembre 1870 la nostra città,
occupata dalle truppe italiane marcianti su Roma, venne finalmente a far parte
della Patria ricostituita. I lavori della bonifica integrale hanno dato un nuovo
impulso alla vita della città, la quale si è estesa ampiamente nel
piano dove il centro abitato tocca oramai per lungo tratto anche la spiaggia di
Ponente.
ARTE - L'architettura civile e quella religiosa
dell'età di mezzo ebbero in Terracina uno sviluppo così
ragguardevole da dare a tutti i quartieri della città alta un aspetto
affatto medievale, che le costruzioni dei secoli posteriori non erano riuscite a
cancellare e che solo le distruzioni dell'ultima guerra hanno profondamente
intaccato. Le fabbriche terracinesi sono quasi tutte da assegnarsi al tempo
compreso fra l'inizio del secolo XIII e la fine del secolo XIV ed esse sono
dominate dalle regole stilistiche dell'architettura ogivale diffusesi da
Fossanova. Portici e loggiati a grandi archi a sesto acuto, balconi e ballatoi
sorretti da mensole, sulle quali poggiano serie di arcatelle a sesto rialzato,
finestre bifore e trifore ad archetti acuti, s'incontrano con grande frequenza
in tutti i quartieri di Terracina alta, come per es. nella piccola piazza
Cancelli, come nel belpalazzo Venditti attiguo alla cattedrale, nei numerosi
palazzetti già esistenti in via della Palma, fra le principali della
Terracina medievale, su cui sfortunatamente si è accanita la furia dei
bombardamenti.
La pietra usata nelle costruzioni è il calcare locale
molte volte accuratamente lavorato in conci che tuttora combaciano
perfettamente, nonostante l'azione corrosiva dei venti saturi di sali marini.
S'incontrano però in moltissimi edifici materiali di natura basaltica,
usati specialmente negli spigoli dei muri e nelle centine degli archi includenti
le bifore e le trifore, aperte nelle facciate delle fabbriche più
antiche: si tratta di basoli ricavati dal lastricato della Via Appia. Molto
materiale, specie le colonne, gli epistili degli architravi, le lastre di marmo,
le mensole, è stato preso dalle antiche costruzioni dell'età
classica.
LA CATTEDRALE - Notizie generali. Il monumento
più insigne della Terracina medievale è la cattedrale. Essa non è
costituita da un edificio originale, ma è l'adattamento a chiesa
cristiana dell'antica cella del Tempio dedicato a Roma ed Augusto. La
trasformazione deve risalire ad epoca molto antica. Già al tempo di S.
Gregorio Magno il tempio pagano serviva al nuovo culto, sebbene la dedicazione
della cattedrale, fatta dal vescovo Ambrosio, rimonti all'anno 1074.
TAVOLA DELL'ASSUNTA - La pittura in Terracina
doveva avere negli edifici religiosi, durante l'età di mezzo,
manifestazioni di notevole importanza, andate quasi totalmente distrutte per le
vicende dei tempi e per l'incuria degli uomini.
L'opera di pittura più
importante rimastaci è la tavola cuspidata, dipinta da ambedue i lati (in
realtà le tavole sono due strettamente combacianti), che si trova in
cattedrale, custodita nella cappella del Sacramento. La tavola non ha iscrizione
che consenta l'identificazione dell'autore che la dipinse e del tempo in cui fu
eseguita; nondimeno, dai suoi caratteri stilistici, può riconoscersi un
saggio cospicuo di quella scuola pittorica fiorita tra la fine del Trecento ed
il principio del Quattrocento nella stessa Terracina (Madonna della Delibera,
affreschi evanescenti in S. Domenico e in S. Francesco) ed in molte città
del basso Lazio. Un solo pittore oggi è noto che rappresenti l'attività
di questa scuola, ed è Antonio di Alatri, seguace di Gentile da Fabriano,
del quale il Museo di Alatri possiede una bella tavola raffigurante il Salvatore
che nei caratteri stilistici molto ricorda quelli della nostra tavola. In questa
le forme sono floride e delicatamente disegnate, i colori vivi e ben fusi,
espressivo l'atteggiamento dei sacri personaggi, eloquente la tenerezza materna
della Vergine, la maestà solenne del Salvatore, la dolce espressione del
Bambino e degli Angeli. Da alcuni particolari e dalla tradizione che fa dipinta
la tavola da S. Luca, si potrebbe pensare che la pittura attuale ne abbia
sostituita altra di epoca più antica.
IL CAMPANILE - Il bel campanile in laterizio
che si trova a sinistra della facciata della cattedrale, deve riportarsi
anch'esso alla metà del secolo XIII. Esso è costituito da quattro
piani, in ognuno dei quali sono aperti quattro piccoli loggiati con arcatelle
gotiche, sorrette da colonnine di marmo. I muri esternamente sono inoltre
decorati di frammenti marmorei antichi e di paste policrome. Il campanile è
impostato su quattro robuste arcate ogivali aperte, di cui la posteriore serviva
d'ingresso secondario alla chiesa. E uno di quei saggi di campanili di cui le
chiese romane hanno bellissimi esempi, innalzati in Roma e nelle regioni
circostanti tra il secolo XII ed il secolo XV. Tl nostro campanile però
se ne distacca per due particolari: il primo è che esso ha la base
praticabile, avvicinandosi così al campanile del Duomo della non lontana
Gaeta; il secondo è che, mentre il sistema strutturale è quello
del romanico laziale, nel largo uso fatto nella sua decorazione delle arcature a
sesto acuto, si palesa la trasformazione operatasi nella regione laziale fin
dall'inizio del secolo XIII dei principi architettonici e la sostituzione
avvenuta di quelli romanici con quelli ogivali, in Terracina derivati
direttamente dalla vicina Fossanova.
IL PALAZZO VENDITTI - L'edificio civile più
bello e conservato è il Palazzo Venditti che sorge immediatamente a
destra della cattedrale. Esso scavalca con un bel fornice la Via Anita Garibaldi
che qui segue il tracciato dell'antica Appia: il fornice ad occidente presenta
un arco a tutto sesto, voltato sulla centina dell'arco Trionfale, che si trovava
all'ingresso del Foro Emiliano: nella parte orientale, invece s'incurva un
elegante arco a sesto ribassato. La fabbrica risale alla prima metà del
Trecento, ma in epoca posteriore ha subito una sopraelevazione fatta con
muratura piuttosto grossolana. Nel primo piano si aprono due graziose finestre,
una trifora sulla piazza ed una bifora verso la scalinata del Duomo, ad archi
spezzati, impostati su colonnette. E da ritenere che nell'età di mezzo
l'edificio fosse la sede del Comune, prima che questa fosse trasportata nel
vicino palazzo di Fondi, distrutto dai bombardamenti, di epoca molto più
tarda.
LA TORRETTA - Poco sappiamo della cosi detta
Torre civica -la Torretta- che s'innalza anch'essa sul foro, di altezza eguale a
quella del Campanile (circa m. 35). La torre, che forse appartenne ad un ramo
della potente famiglia Rosa, subi in epoche diverse vari rimaneggiamenti: appare
evidente, infatti, che le finestre gotiche sono una trasformazione apportata in
età posteriore a quelle della primitiva costruzione che può
riferirsi alla prima metà del Duecento.
CASA - TORRE DI VIA SS. QUATTRO - A Terracina
esistono parecchie altre case-torri; quasi tutte, però, scapitozzate. La
più imponente è quella che si trova in Via SS. Quattro (circa m.
30 d'altezza) la quale nel lato orientale ha murata un'iscrizione che ricorda
come nel 1280 GREGORIUS DE ACZO EMIT HANC DOMUM. La torre, dalle pietre annerite
dal tempo e dall'umidità, per lo spesore delle sue muraglie, dalle scarse
e strette aperture, più che una "domus" deve considerarsi uno
strumento di guerra, dove asserragliarsi e da dove minacciare nelle frequenti
lotte intestine che per secoli hanno travagliata la città.
PORTA MAGGIO - La porta deriva il nome da porta
Maior. I basamenti delle due grandi torri che fiancheggiano la porta sono
formati di strati di opera isodoma di calcare, quasi sicuramente di epoca
antica, poichè qui ha inizio la primitiva cinta fortificata della città,
e fin dall'età etrusco-volsca dobbiamo qui porre l'ingresso principale
della città stessa. Le due torri hanno le pareti sulla strada affrontate
ma divergenti dall'interno verso l'esterno. Sulla porta medievale s'innalzava un
alto muro merlato forato da feritoie, abbattuto nel 1780 per favorire la
circolazione dell'aria nelle vie interne cittadine. Nello stesso anno fu dato un
nuovo ingresso alla città a Porta S. Gregorio, I'attuale porta Romana.
MURA BIZANTINE E MEDIEVALI - Sull antica cinta
volsca e romana posano le mura bizantine e medievali, la cui importanza non è
certamente inferiore a quella dell'antica. La struttura delle mura è in
opera mista di blocchetti squadrati in file orizzontali alternate
irregolarmente, con una cornice terminale di mattoni sorretta da piccole mensole
di pietra e di marmo. Addossate alle mura vi sono numerose torri le quali, dai
caratteri strutturali, si rivelano affini a quelle della prima età
bizantina, erette non solo a Roma e in altre città d'Italia, ma nella
stessa Costantinopoli. Nella parte rivolta a settentrione le mura sono
conservate fino al cammino di ronda, con tutte le torri in piedi trasformate in
case di abitazione nel 1780. Il cammino di ronda è percorribile ancora
oggi interamente (vi si sale da due scalette: una a sinistra di Porta Nuova e
l'altra dietro la chiesa di S. Giovanni) ed è interessantissimo perchè
è divenuto una pubblica strada, che serve di accesso alle case addossate
alle mura.
Anche le mura della città bassa medievale (mura
comunemente denominate baronali), largamente abbattute per ragioni di viabilità,
sono state costruite forse nella stessa epoca in cui fu eretta la cinta murata
del primo medioevo, per sbarrare un tratto della Via Appia traianea, sulla quale
erano aperte infatti due porte: la porta est, che si vede ancora entrando
nell'orto Borelli, e la portá ovest sotto il palazzo Cardinale (le
Scalette) oggi completamente scomparsa, ma di cui s'individuano i resti delle
due torri che la proteggevano.
IL CASTELLO - Il Castello medievale è
detto anche Castello dei Frangipane o Rocca Traversa. Il torrione è
sostenuto da un basamento di blocchi rettangolari così simili alle
costruzioni antiche che sembrerebbe del periodo repubblicano. Le mura del
Castello accusano parecchi rifacimenti, che sono in rapporto alle vicende
turbinose della sua esistenza. Eretto forse nel secolo XI, fu occupato per
tradimento nel 1143 dai Frangipani che avevano avuto l'investitura feudale di
Terracina da papa Celestino II. Rioccupato dai terracinesi nel 1202, esso
divenne simbolo e presidio della "libertas" comunale. Nei primi anni
del '400 accolse una guarnigione pontificia, fu affidato ad un castellano e
forse vi dimorò lo stesso governatore della città. La guarnigione
vi rimase fino ai primi anni del secolo XIX, allorchè fu trasformato in
conservatorio per l'educazione delle zitelle. Il 4 settembre del 1943 il
Castello, colpito da bombe alleate, fu danneggiato gravemente e reso quasi
inaccessibile. Caratteristica ed inusitata la sua forma data da parallelepipedi
stretti che si innalzano a gradoni, sull'ultimo dei quali poggia una cupoletta.
La sua sagoma, dall'aspetto inconfondibile, dà una nota particolare al
panorama della città.
CHIESA E CONVENTO DI S. DOMENICO - La tradizione
fa rimontare allo stesso S. Domenico le umili costruzioni originarie, edificate
nei primi decenni del secolo XIII dall'abate di Fossanova Stefano di Ceccano.
Esse furono successivamente ampliate nel 1289, dal P. Alberto da Terracina O.P.,
vescovo di Fondi. La chiesa, già un tempo pregevolissima per stile
architettonico e decorazioni di pittura e di marmo, dopo un lungo stato di
completo abbandono è stata riattata negli ultimi anni con la
ricostruzione del tetto sfondato. La facciata presenta un portale sormontato da
un arco a tutto sesto impOstato su un archivolto, sul quale si apre un mirabile
rosone a pilastrini ragglanti, che disegnano un arabesco ad archi gotici,
interessantissimo; la travature del soffitto a capriate poggiava su mensoloni
scolpiti a figure umane, oggi sostituiti da mensoloni di legno; forma singolare
hanno il transetto ed il coro, fiancheggiato da due profonde cappelle. La ricca
decorazione pittorica con stratificazione di affreschi di epoche diverse è
andata completamente distrutta nell'ultimo rifacimento.
CHIESA DI S. FRANCESCO E CONVENTO DEI CONVENTUALI
- L'origine risalente all'anno 1222, dalla tradizione è attribuita
allo stesso Serafico. La chiesa, costruita al principio secondo le regole
dell'arte gotica fossanoviana, subì a piu riprese radicali
trasformazioni, che ne avevano del tutto alterato lo stile primitivo. Distrutta
quasi affatto dai bombardamenti durante l'ultima guerra, è rimasto in
piedi il piccolo campanile, dalla caratteristica, arcaica cupoletta a pan di
zucchero.
Nel convento furono ospitati Alfonso V d'Aragona nel 1456,
l'imperatore Carlo V nel suo passaggio per Terracina nel 1535 e Sisto V nel
1589.
CHIESA DELL ANNUNZIATA - L'edificio, quasi
completamente distrutto, mostra un piccolo elegante portale sormontato da un
architrave a fregi vegetali e faunini. L'artista che lo scolpì verso la
metà del 1200 Vi ha inciso il suo nome: MAGISTER ANTONIUS DE PIPERNO ME
FECIT.
CHIESA DELLA MADDALENA - Se ne vedono i resti
sotto la palazzina del prof. dott. Decio Salvini, ai piedi delle rocce
strapiombanti di Monte S. Angelo. Appartenne dapprima ai cavalieri templari che,
ancora nella seconda metà del 200, possedevano e custodivano la rocca
della non lontana S. Felice Circeo. Nell'ambiente occupato dalla chiesa,
ricavato da un'antica costruzione in reticolato, sono interessanti gli affreschi
molto evanescenti del secolo X o XI rappresentanti La Maddalena, S. Cesario ed
un altro Santo. La chiesa venne dedicata alla Maddalena, protettrice dei
lebbrosi, che dovevano transitare frequentemente sull'Appia e che venivano
accolti o relegati in locali destinati a leprosario attigui alla chiesa. Di vivo
interesse sono i nomi graffiti sopra un tratto d'intonaco nell'interno di una
cappella, tracciati in caratteri gotici e qualcuno anche in greco. Sono nomi di
cavalieri del Tempio appartenenti, pare, alle commende d'Italia e di Provenza.
CHIESA NUOVA O DEL
SALVATORE - La prima pietra della fabbrica, secondo
il prof. arch. Bruno Apolloni progettata dal Valadier che disegnò anche
la grandiosa esedra antistante al tempio, fu gettata da Pio VI nell'anno 1795.
Ma, sospesi i lavori al loro inizio, in seguito agli sconvolgimenti politici
seguiti alla invasione francese, essi vennero ripresi nel 1830 su nuovo progetto
dell'architetto bolognese Antonio Sarti e condotta a termine nel 1846.
Il
tempio, per magnificenza e purezza di linee, è una delle manifestazioni
più perfette e meno fredde dello stile neoclassico. Dal pronao superbo
formato da sei enormi colonne ioniche sorreggenti un bellissimo timpano, si
entra nell'interno della chiesa a tre navi, separate da colonne anch'esse
ioniche, con navata a crociera ed abside a deambulatorio. Sulla crociera è
impostata una cupola di mirabile effetto per grandiosità di sviluppo ed
armonia architettonica. In una cappella vi era un quadro raffigurante S. Felice
di Valois che redime gli schiavi, del pittore napoletano Tommaso De Vivo, opera
degna d'attenzione, andata perduta durante l'ultima guerra. Pure perduta è
andata una grande tela del Fracassini, rappresentante Gesù che cammina
sulle acque, quadro pregevole per l'insieme della composizione e per la vivacità
e la fusione dei colori.
LA PIETA DEL BARUZZI - L'altare maggiore doveva
essere decorato da un ammirevole gruppo in marmo lunense, rappresentante la Pietà,
colla figura della Vergine a piè della Croce, col Cristo morto in seno, e
colla Maddalena prostrata ai suoi ginocchi. Questo gruppo, modellato dal Canova,
ma scolpito dal suo discepolo, lo scultore bolognese Cincinnato Baruzzi, è
collocato oggi nella prima cappella a destra della chiesa. La scultura è
una vera opera d'arte e non sarebbe indegna dello scalpello del sommo Canova,
tanto la composizione della drammatica scena, la bellezza classica delle figure,
I'eleganza e la correttezza del movimento delle vesti, la trattazione
delicatissima del marmo si impongono all'osservatore.