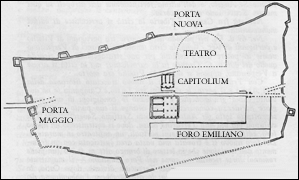
TERRACINA - Città murata, Foro, Capitolium
|
MURA URBANE - Il primo impianto della città
murata, che è forse da attribuire all'età della dominazione
etrusca ma che secondo altri è del periodo volsco, utilizzava nel miglior
modo la giacitura naturale della "città alta", la quale sorge
su uno sperone roccioso ad andamento irregolare, che, da una parte pecipita
verso il mare, è, per il resto, dove più, dove meno acclive, tra
Porta Maggio e la zona che dal Castello dei Frangipane scende a Piazza Santa
Domitilla. L'asse maggiore dell'assai grossolano quadrilatero corre da ovest ad
est, costituisce il decumano della città e misura all'incirca 350 metri;
I'asse minore non supera in nessun punto la larghezza di 200 metri. La porta più
importante di questa antica città murata era quella a ponente, e cioè
verso i fertili terreni ai piedi del monte Leano, e verso le paludi: è la
porta detta Maggio (da maior), al centro di uno dei lati brevi del quadrilatero.
Il lato lungo nord può esser segnato dalla murazione che dalla estremità
orientale di Via Pastrengo giunge fino alla "Porta Nuova" e di qui
fino al Castello dei Frangipane: nel quale castello è con ogni
verosimiglianza da riconoscere la prima acropoli della città murata.
In periodo successivo, e in relazione all'importanza militare sempre maggiore di
Terracina (che fu considerata posizione chiave per eserciti provenienti dalla
Campania, cosicché si ubicarono presso Terracina le "Termopili
d'Italia") I'acropoli fu spostata a levante, al bastione della Vignola di
S. Francesco o dell'odierno Ospedale, e l'abitato che occorse proteggere
militarmente comprese le estreme pendici occidentali dello sperone su cui fu
costruito il primo oppidum, e cioè si estese per 225 metri circa da Porta
Maggio alla "Porta Romana".
Un periodo di grande fervore edilizio
si ebbe a Terracina nei primi decenni del I secolo a. C., e cioè nell'età
di Silla, e a questo periodo viene assegnata la nuova ultima acropoli a Monte S.
Angelo, con le sue nove torri circolari in opera incerta sillana, fornite di
camere di manovra, ubicate a distanze irregolari, e accessibili dal cammino di
ronda. Taluno ha attribuito tale acropoli (che è a pietrame grosso
cementato in modo piuttosto trascurato) ad età annibalica; ma Giuseppe
Lugli fa osservare che l'attribuzione è inaccettabile, perchè alla
fine del III secolo a. C. ancora dominano l'opera quadrata nei paesi del tufo, e
l'opera poligonale nei paesi che, come Terracina, abbondano di pietra calcare:
I'opera incerta era invece sconosciuta in quel tempo, quale paramento esterno,
specie nelle mura urbane.
Notevoli sono a Terracina gli avanzi superstiti
delle mura urbane in opera poligonale, più o meno regolare e accurata:
non imponenti sono i resti di tali mura al castello dei Frangipane, dove fu
verisimilmente stabilita la primitiva acropoli di Anxur; eccezionalmente
imponenti sono le mura che rivestono l'angolo sud-est del colle su cui sorge la
cosiddetta Vignola di S. Francesco (oggi Ospedale civico). I due lati del
grandioso bastione fanno un angolo di quasi novanta gradi, di cui il meridionale
va a morire contro la roccia e l'orientale "appare restaurato più
volte verso l'estremità, sia in età sillana, sia in età
medievale e moderna" (Lugli). L'opera poligonale è a bugne piuttosto
grosse e irregolari; nella sovrapposizione dei blocchi vi è già
una pronunciata tendenza ai piani orizzontali; lo spigolo del bastione corre con
regolarità perfetta; nella parte più alta i blocchi sono di
dimensioni più piccole.
In occasione dell'ultima guerra alcune bombe
cadute sul bastione hanno danneggiato una parte del coronamento delle mura.
La parte più notevole della Terracina antica e medievale è
quella che si raggruppa intorno al Foro Emiliano o Piazza del Municipio.
ARCO LAPIDEO D'INGRESSO DELLA VIA APPIA NEL FORO EMILIANO DAL LATO DELLA
CAMPANIA - Salendo da Terracina bassa alla zona
monumentale della Terracina romana per la Salita dell'Annunziata, il primo
nobile rudere che s'incontra sulla destra è un grande arco lapideo. Non è
un arco eretto per onorare un imperatore o un determinato personaggio, come si
pensava prima che le distruzioni provocate dal bombardamento aereo del 4
settembre 1943 e successivi rivelassero la vera natura del monumento, è
il fastoso ingresso della Via Appia nel Foro Emiliano per chi veniva dalla
Campania. E non è un arco a un solo fornice, ma un arco quadrifronte, di
cui almeno tre lati dovevano risultare aperti.
La fronte che guardava verso
il foro, che è la fronte meglio conservata e che si sviluppa da nord a
sud- misura in larghezza m. 6,40 ed ha una luce di m. 4,23; la fronte da ovest
ad est è larga m. 5,37 ed ha una luce di m. 3,53. L'arco sorge su quattro
piedritti dei quali i due volti verso il foro sono integri, gli altri due sono
ridotti a modesti monconi, ma hanno misure analoghe. L'altezza della intera
fronte raggiunge i m. 6,34 sino al sommo della cornice monumentale, la quale si
profila con sagome molto eleganti conservateci anche in un disegno di
Baldassarre Peruzzi. Dai piedritti fa risalto, nella fronte volta al foro, una
leggera lesena coronata da un basso capitello su cui poi si leva la trabeazione
monumentale; al di sopra della cornice lapidea sono i resti di una struttura
muraria, che dovrebbero appartenere alla volta (a crociera ?) di copertura
dell'arco quadrifronte.
Al di sotto dell'arco si è messo in luce un
tratto perfettamente conservato della Via Appia, in allineamento con il tratto
della via scoperto sotto le rovine del palazzo del Comune sul Foro Emiliano.
Che l'arco risulti poi all'estremo limite orientale dell'area del Foro risulta
accertato dalla circostanza che al di sotto degli edifici di questo tratto della
Via dell'Annunziata, dal lato meridionale della via, muoiono i lastroni della
pavimentazione del foro.
Chi osservi il taglio quasi verticale che nel
senso del suo spessore presenta l'arcata superstite di questo ingresso
monumentale, dalla parte che volge verso l'odierna Via dell'Annunziata, non si
può esimere dal dubbio che una seconda arcata seguisse alla prima in
direzione di mezzogiorno. Una serie di arcate limitava dunque il foro sul lato
breve di oriente? Una risposta non può ora essere data; notiamo comunque
che nel disegno che il Peruzzi ci ha lasciato del foro di Terracina è qui
segnato un edificio che reca, sulla fronte e sui lati, una serie di pilastri,
che sarebbe la basilica d'età romana.
Proseguendo per la Via
dell'Annunziata, si entra nel Foro Emiliano.
FORO EMILIANO - Si chiama Foro Emiliano la
grande piazza su cui prospetta la Cattedrale di S. Cesario, e su cui prima
dell'ultima guerra prospettava anche il palazzo municipale, dal quale derivò
alla piazza la denominazione di Piazza del Municipio. La piazza corrisponde
appunto al Foro dell'età romana; e la sua pavimentazione è ancora
quella antica, eseguita per iniziativa e a spese di un Aulo Emilio figlio di
Aulo, come testimonia l'iscrizione
A(ulus) AEMILIUS A(uli)
E(ilius) STRAVI[t ..]
incisa in grandi lettere di bronzo (oggi
mancanti), di un piede romano di altezza (m. 0,30) in una fila di lastroni
rettangolari di pietra grigio chiara, correnti nel senso della larghezza della
piazza (da nord a sud), e precisamente sull'asse mediano delI'area dell'antico
foro.
Nel corso dei secoli parte dell'area del foro emiliano venne
abusivamente occupata da costruzioni molteplici sia sui lati lunghi, sia sui
lati brevi. Essendosi disgraziatamente accanito il bombardamento aereo
dell'ultima guerra proprio sulla piazza e sulle sue adiacenze, possiamo oggi
restituire al foro, su tutti i lati, le dimensioni originarie.
Per quel che
riguarda l'iscrizione, si sono recuperate sei lettere del verbo stravi[t] "pavimentò".
Nella parte di iscrizione oggi non più superstite è possibile vi
fosse qualche altra lettera, come, ad esempio, P(ecunia) S(ua).
Sul lato
nord (più precisamente dovrebbe dirsi nord-est) che è uno dei lati
lunghi del foro la distruzione del palazzo del municipio ha permesso, allorchè
si è provveduto alla rimozione delle macerie, di mettere in luce circa 25
metri della strada lastricata romana, certamente la Via Appia, decumano della
città, utilizzata, quando ebbe attuazione il progetto del foro emiliano,
quale limite settentrionale del foro stesso.
Sul lato sud (meglio
sud-ovest) I'area dell'antico foro era stato parzialmente invaso per la
costruzione dell'episcopio, della "Torretta" e di altri edifici. La
rimozione delle macerie ha consentito di ritrovare la cunetta marginale di scolo
delle acque, poi un breve ripiano, poi tre gradoni per l'altezza complessiva di
95 centimetri, poi ancora un ripiano, limitato da un muretto alto 60 centimetri,
e un secondo più ampio ripiano in corrispondenza del sommo della volta
delle gallerie di sostruzione del foro, correnti lungo questo lato sud (tra il
margine sud del foro e il ciglio estremo esterno di queste gallerie di
sostruzione la distanza risulta di m. 19,60).
Dal lato ovest, e cioè
dal lato del Duomo si è constatato, mediante un saggio praticato nel
cortiletto a ponente del fabbricato dell'episcopio, che sull'area del foro è
costruita, per una profondità di m. 7,14 tutta la gradinata del Duomo
antistante al colonnato del pronao e del campanile.
Infine dal lato est la
pavimentazione antica del foro continua al di sotto degli edifici della Salita
dell'Annunziata sino alI'altezza del fornice marmoreo che rimane a cavallo della
Via Appia, e che ora deve esser considerato l'ingresso monumentale al foro per
chi veniva dalla Campania. Partendo dalle constatazioni esposte, le dimensioni
reali del foro risultano come segue: nel senso dell'asse maggiore, e cioè
da ovest ad est il foro misura m. 83,46; nel senso dell'asse minore e cioè
da nord a sud, il foro risulta di m. 33,32. Tradotte in piedi romani di m. 0,296
le due misure di m. 83,46 e 33,32 corrispondono rispettivamente a 282 e a 112
piedi. Può apparire ipotesi plausibile che l'architetto urbanista si sia
originariamente proposto di dare al foro le dimensioni di piedi 300 X 120:
condizioni particolari del terreno non gli permisero di raggiungere queste due
cifre tonde.
Un cenno particolare merita il tratto della Via Appia che
costituisce il limite nord del foro. La via è larga m. 4,12, cioè
quasi esattamente 14 piedi romani; dal lato del foro la via è difesa da
paracarri a distanze regolari di m. 1,76 (e cioè di 6 piedi), dal lato
verso monte (che è in pendio) la via ha un marciapiede in lastroni di
pietra disposti in senso normale all'asse della strada, i quali coprono la fogna
per la raccolta delle acque di pioggia e delle acque luride.
Un altro cenno
particolare è da fare per le sostruzioni di terrazzamento del Foro.
Risultando, lo sperone di monte, in declivio sul lato volto al mare, si rese
necessaria, per dare al foro le dimensioni e la sistemazione organica voluta,
una triplice galleria di terrazzamento, che corre da ponente a levante. Delle
tre gallerie le due più esterne (cui fa da limite, dal lato mare, il "Vicolo
di Sottosusto") sono intercomunicanti, e sono divise una dall'altra da un
muro sostenuto da pilastri. Le gallerie hanno inizio all'altezza della fronte
posteriore del presunto tempio di Roma e di Augusto, ed hanno termine al di là
della piazza del foro, all'altezza, circa, della Piazza S. Domitilla. Quanto
alla terza galleria, più vicina al limite meridionale del foro, essa è
naturalmente meno alta delle altre due perchè la roccia dello sperone di
monte va gradatamente alzandosi verso la piazza, e correrebbe dalla fronte
posteriore del tempio di Roma e di Augusto sino al limite di levante del foro,
alquanto prima di Piazza S. Domitilla.
EDIFICI MONUMENTALI SUL LATO NORD DEL FORO -
Nel suo noto disegno del Foro di Terracina Baldassarre Peruzzi segna sul lato
nord del Foro un edificio templare esastilo periptero (nel complesso, 24 colonne
sui quattro lati). Nel piano superiore della casa abitata al presente dalla
famiglia Aceto, con ingresso dalla Salita Castello n. 2, si vede ancora, in sito
e incorporata parzialmente in un muro, la parte superiore di una bella, grossa
colonna scanalata cui è sovrapposto un capitello corinzio.
TEMPIO MAGGIORE DEL FORO EMILIANO (DEDICATO A ROMA E
AD AUGUSTO ?) - A chiudere con alto decoro il lato breve occidentale del
Foro Emiliano fu eretto, quando venne attuata la sistemazione del foro, un
grande tempio divenuto poi, in età cristiana, il Duomo o Cattedrale di S.
Cesario.
E ipotesi assai suggestiva l'attribuzione del tempio al culto di
Roma e di Augusto. L'ubicazione dell'edificio a chiusura di uno dei lati brevi
della piazza, e il fasto e la finezza del rivestimento marmoreo superstite della
cella del tempio sarebbero in favore di questa attribuzione; e a questi
argomenti se ne aggiungerebbe un terzo, e cioè la esistenza in Roma,
nella chiesa di S. Agnese, di un grande blocco di marmo proveniente da Terracina
e appartenente a un epistilio monumentale, con l'iscrizione
Romae et
Augusto Caesari divi [f(ilio)] A. Aemilius a. f. ex pecunia sua f. c. (C. I. L.,
X, 6305)
Aulo Emilio è quello stesso personaggio che ha
curato, a sue spese, la pavimentazione del foro di Terracina.
Ma
l'iscrizione già esistente a S. Agnese è oggi dispersa, e, quindi,
occorre andare cauti nel riferire l'epigrafe al grande tempio del Foro Emiliano,
sia per la ragione che la trabeazione della fronte del tempio doveva esser
lignea data l'ampiezza dell'intercolumnio, sia perchè esiste a Terracina
un secondo frammento di epistilio, più tardo e in caratteri diversi e più
grandi, in cui si leggono le parole incendio c[onsumptum ?] (C. I. L., X, 6333).
I due testi non si accorderebbero fra loro. Potrebbe peraltro supporsi che
l'epigrafe fosse ripetuta sul muro di uno dei lati.
Altri, e tra essi il
Peruzzi nel suo noto disegno, attribuiscono il tempio ad Apollo, poichè
tale tempio è ricordato negli atti della Passione di S. Cesario.
Comunque, del tempio sono riconoscibili le favisse ed è superstite una
parte del rivestimento marmoreo, specie sui lati di nord e di ovest. Partendo
dall'esame delle favisse (di m. 14,80 X 4,05 ciascuna), ed anche dallo spessore
dei muri che dividono una favissa dall'altra, e dalla circostanza che a metà
delI'asse trasversale del tempio il muro nord-sud di divisione di una favissa
dalla prossima ha uno spessore doppio del consueto. Si tratterebbe di un tempio
prostilo tetrastilo, con pronao profondo quanto è profonda la cella e
nobilitato da una triplice fila di quattro colonne ciascuna, oltre le
semicolonne levantisi sulla fronte della cella, così come si levano
all'estremo degli altri tre lati della cella stessa. Per ciò che si
riferisce al rivestimento marmoreo esterno della cella, colpiscono vivamente la
finezza delle semicolonne scanalate con base attica, la bella fascia a foglie
d'acanto corrente tra i lastroni verticali (ortostati) che si levano dallo
stilobate, il muro isodomo delle pareti, e lo zoccolo scorniciato aggettante al
piano dello stilobate.
Il rivestimento marmoreo delle pareti della cella
sui lati di nord e di ovest è stato sempre visibile; nel novembre 1955 è
stato riconosciuto in un vano secondario del duomo adibito a sagrestia un altro
avanzo, scalpellato, del rivestimento marmoreo del lato di ponente di detta
cella.
Imponente è il muro in grandi parallelepipedi di pietra
disposti in corsi regolari, che costituisce la sostruzione del tempio sulla
fronte postica, a ovest, nella Contrada Posterula. In corrispondenza del lato
nord della cella si veggono ugualmente di sotto delle semicolonne della cella e
ai lati degli accessi alle favisse, analoghe sostruzioni in parallelepipedi di
pietra.
TEMPIO A TRE CELLE O CAPITOLIUM DELLA CITTA' -
Subito al di là del Foro, dal lato di ponente della piazza, si era da
gran tempo riconosciuta l'esistenza di un tempio a tre celle, un capitolium,
come solevano chiamarsi questi templi caratteristici delle colonie romane,
dedicati alla triade capitolina, Giove, Giunone e Minerva. Il bombardamento
aereo dell'ultima guerra avendo distrutto tutte le costruzioni elevate al di
sopra dell'antico tempio, ci ha permesso di liberare e restaurare l'edificio
antico, di cui si conoscevano già le favisse, due delle pareti esterne,
lo spigolo di nord-est, infine il basamento della colonna angolare del pronao a
sud-ovest.
Il tempio, oggi libero da ogni lato, ha il suo prospetto sulla
Via Appia che, venendo da Porta Maggio, costituiva il decumano della città.
Della pavimentazione della Via Appia sul prospetto del capitolium si vedono
ancora alcuni basoli, insieme col marciapiede antico, che corre a nord della via
e che risulta tutto di lastroni di pietra, alti m. 0,30 (1 piede romano), lunghi
m. 1,32 e sovrastanti alla fogna, larga due piedi romani (m. 0,59).
Ma era
questo il capitolium originario della colonia romana del 329 a. C.? L'ipotesi è
forse da escludere.
Sulla fronte rovescia della cella del capitolium
odierno si è messa in luce, nello sgombro delle macerie, un'altra strada,
finora ignota, corrente anch'essa da ovest ad est nel senso del decumano. Sorge
quindi il sospetto che in età più antica di quella cui risale il
capitolium della fase superstite, la Via Appia avesse un corso alquanto diverso,
e cioè che, entrando in città da Porta Maggio, si tenesse un poco
a nord del decumano che oggi imbocca il Foro Emiliano. Il tratto del più
antico decumano che è stato messo in luce aveva una sostruzione in opera
poligonale, che fu parzialmente distrutta e sostituita da un rozzo reticolato di
pietra, allorchè furono gettate le fondazioni del capitolium quale noi lo
conosciamo; cosicché non ci pare dubbia l'esistenza di un capitolium più
antico.
Il capitolium della fase giunta sino a noi ha pianta di tempio
prostilo tetrastilo, con ante sporgenti m. 2,33 (8 piedi romani). In fronte, da
ciglio a ciglio della cornice del podio, il tempio misura m. 16,54 (m. 15,96 al
vivo del dado del podio, tra esterno ed esterno delle colonne estreme); e misura
sui fianchi, rispettivamente come sopra, m. 16,33 e m. 15,80. In definitiva la
pianta può ritenersi quella di un quadrato di 56 piedi di lato (= m.
16,57): quadrato che torna ugualmente se si prende come base del calcolo la
distanza tra centro e centro delle colonne estreme della fronte in m. 15,08 (=
51 piedi), e la distanza tra centro della colonna angolare a SE e centro della
lesena angolare a NE.
I muri sono in opera reticolata a due colori: un
ordine di piramidette di pietra chiara locale si alterna orizzontalmente e a
linee sfalsate con un ordine di piramidette in tufo scuro. Il reticolato non era
però, a quanto sembra, destinato ad esser visto, poichè nella
parte inferiore di taluna delle pareti qualche lembo di intonaco superstite fa
pensare che il reticolato stesso avesse un rivestimento di intonaco (opus
tectorium) bene aderente, data la scabrosità della fronte delle
piramidette. Tra fronte e fronte in opera reticolata la parte interna dei muri è
in opera cementizia.
I due spigoli del tempio sulla fronte posteriore, e le
fronti e i risvolti delle ante risultano però in pietra travertinosa, e
recano lesene larghe m. 0,88 (3 piedi romani), a nove scanalature. Nella loro
interezza le lesene misurano sino al sommo dell'abaco m. 7,50.
Il tempio è,
come si è detto, a tre celle. Le celle misurano costantemente m. 9,25 in
lunghezza, ed hanno altresì all'incirca una larghezza costante (la cella
centrale ha una larghezza di m. 4,58, le celle laterali m. 4,53). I muri
divisori tra cella e cella hanno uno spessore di m. 0,53; i due muri esterni uno
spessore di m. 0,60. Dei muri delle celle verso il pronao sono superstiti
elementi modestissimi; bene riconoscibile, per quanto danneggiata, è la
soglia in pietra della cella centrale.
Sul pronao, il cui ripiano misura m.
14,76 (tra interno e interno dei muri delle ante ed escluso il risalto delle
ante stesse) per una profondità di m. 4,78 (dai muri frontali delle celle
all'asse o mezzeria delle colonne), riposano le quattro colonne della fronte
monumentale, alte complessivamente con l'abaco m. 7,50, e rese preziose da 22
scanalature rivestite di stucco. Delle colonne (che hanno un diametro di m. 0,88
e si alzavano su una base attica alta m. 0,265) non rimangono che quattro
elementi pertinenti alla colonna dello spigolo sud-ovest, e che hanno un'altezza
complessiva di m. 5,32. Tra asse ed asse delle colonne è una distanza di
m. 5,025, sicché è a pensare che la trabeazione fosse lignea.
Al pronao si accedeva mediante una rampa di 2 gradini che salivano in
corrispondenza delle due colonne centrali, partendo da un ripiano più
basso di m. 2,46 rispetto allo stilobate; detto ripiano era a sua volta
imminente sulla strada in pendio, così che l'accesso al ripiano si
suppone esistesse sul fianco orientale. Il nucleo interno dello stilobate è
tutto in opera cementizia; all'altezza o piano dello stilobate corre lungo tutto
l'esterno del tempio, sui lati di ovest, di nord, e di est, uno zoccolo sagomato
in pietra, sotto cui il reticolato continua ad elementi di sola pietra.
Di
particolare interesse dal punto di vista decorativo è il basamento
superstite della colonna angolare di sud-ovest, basamento in pietra
travertinosa, sagomata in alto e in basso (gola diritta sul plinto, e gola
rovescia al sommo del dado). Il basamento è alto complessivamente m.
2,46; e al basamento fa seguito, sul fianco del tempio, un muro che risulta di
elementi di tufo.
Al di sotto del tempio sono le favisse, cui si accede da
un andito largo m. 2,34 e che corre lungo tutto il fianco occidentale del podio;
la porta centinata di accesso alle favisse è larga quattro piedi romani
(m. 1,18). La favissa d'ingresso che è sottostante al pronao misura m.
13,90 x 3,80, ed è alta sull'asse della volta m. 3,50. Le tre favisse
sottostanti alle tre celle del tempio, a cui si accede per tre porte dalla
favissa d'ingresso, hanno tutte una lunghezza costante di m. 8,60, un'altezza di
m. 3,70, ed una larghezza che rispettivamente è di m. 4,40 per la favissa
centrale, e di m. 4,10 per le due favisse laterali. Le favisse hanno, tutte,
opera reticolata di sola pietra locale non alternata con piramidette di tufo.
Gli elementi acquisiti con i lavori di liberazione, di isolamento e di
restauro del tempio a tre celle (1946-1948) mentre sono degni di particolare
rilievo per le nostre accresciute conoscenze di un monumento così
insigne, confermano, in relazione alla struttura dei muri, la datazione
attribuita al tempio da Giuseppe Lugli, il quale riporta il Capitolium
all'incirca alI'età del secondo triumvirato (a. 43 a. C. e segg.).
ARCO LAPIDEO D'INGRESSO DELLA VIA APPIA NEL FORO EMILIANO DAL LATO DI
PONENTE, VOLTO A ROMA - A chi tenga presente l'esistenza
di un ingresso monumentale al Foro Emiliano sulla Via Appia dal lato volto verso
la Campania, vien fatto spontaneo di pensare che sulla Via Appia, nel punto in
cui essa imbocca il Foro, dovesse esistere un ingresso monumentale anche dal
lato volto verso Roma. L'esistenza di tale nobile ingresso non è oggi
dimostrabile perchè la costruzione del palazzo Venditti (che scavalca con
un fornice l'antica Via Appia nel tratto corrente tra la fronte, libera, del
Capitolium e il Foro) deve avere incorporato in parte e in parte distrutto tale
ingresso monumentale. Che però il fornice romano esistesse si può
indurre con tutta verosimiglianza, perchè chi guardi attentamente la
fronte posteriore del palazzo Venditti constata che in detta fronte, a destra, è
incorporato un antico piedritto in blocchi di pietra, sul quale, alla giusta
altezza delI'imposta di un arco, si vedono tuttora due piccoli conci a cuneo
appartenenti a un'arcata.
TEATRO D'ETA ROMANA - Talune strutture murarie
conservate presso la Piazza di Porta Nuova subito a nord del Capitolium, e
precisamente alcuni tratti di tre muri curvilinei romani concentrici, e
l'andamento generale curvilineo dei fabbricati moderni della zona inducono a
sospettare che esistesse qui un antico teatro. Solo approfonditi e notevoli
lavori di saggio o di scavo potranno mutare in certezza quella che sinora è
verosimile induzione.
Cosiddetto TEMPIO DI MINERVA
- Verso l'estremità occidentale del bastione di San Francesco,
imminente al Parco della Rimembranza, si vedono gl'imponenti avanzi del
cosiddetto Tempio di Minerva. E' un muro o basamento di sostruzione, in blocchi
parallelepipedi lapidei di grandi dimensioni (taluni sono lunghi in fronte quasi
due metri), disposti per fianco e per testata, in file orizzontali assai
accurate. Il basamento, lungo circa 25 metri, raggiunge pressoché sette
metri di altezza ed ha soprattutto i corsi più bassi in bugnato grezzo.
La pertinenza del muro a un tempio di Minerva è del tutto ipotetica, e si
fonda solo sul fatto che scrittori antichi attestano l'esistenza di un tempio di
Minerva in Terracina (JULIUS OBSEQUENS, De prodigiis).